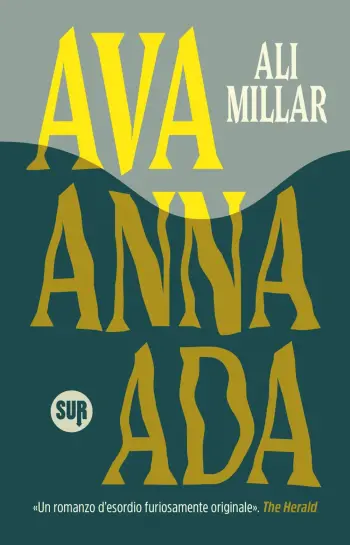Raffaele Lezzi è uno scrittore che racconta l’animo umano andandone a scandagliare le debolezze e i guizzi. Non ha paura di rendere fragili i protagonisti delle sue storie e ama farli viaggiare. Gli abbiamo fatto qualche domanda sui suoi due romanzi, Cosa ci rende umani (Ensemble) e Finali (Venturaedizioni). Da una parte abbiamo Tommaso, che si ritrova a Lisbona senza sapere come ci è arrivato, senza sapere che in Italia ha lasciato una moglie e una figlia e il suo lavoro. Tommaso ha un’amnesia e in Cosa ci rende umani lo seguiamo mentre affronta i segreti del suo passato. Protagonista di Finali è invece Pietro, un ragazzino dislessico di cui leggiamo tutta la vita, dalla sua passione per il calcio al conflitto col fratello, alla storia d’amore con una donna che insegue da sempre.
Raffaele Lezzi ha scritto i suoi romanzi nei laboratori della Scuola Genius e insieme a Luigi Annibaldi abbiamo visto crescere piano piano le sue storie.
Ti sei chiesto se c’è una poetica comune tra i tuoi due romanzi, Finali e Cosa ci rende umani?
C’è sicuramente: innanzitutto la malinconia. Io la chiamo “il west”, altri la “saudade”: la fascinazione per ciò che declina, come il sole dietro l’orizzonte; il rimpianto per quello che ci siamo lasciati alle spalle e non ritornerà; addirittura la nostalgia del futuro che si prova quando stai vivendo un momento bellissimo e già pensi a quanto ti mancherà. Tommaso, il protagonista di Cosa ci rende umani, il west se lo è addirittura tatuato su un braccio: una rosa dei venti con il west più marcato.
Un altro aspetto in comune che hanno i due romanzi è l’attrazione per i segreti, a come definiscono la vita dei protagonisti e di chi gli sta intorno. Tutti, anche le persone apparentemente più limpide, hanno qualcosa da nascondere: è una delle cose che ci rende umani. E quando ripensiamo ai momenti più belli della vita e ai nostri segreti, in molti casi scopriamo che coincidono…
Nel tuo secondo romanzo, Finali, racconti la storia di Pietro attraverso le finali dei mondiali di calcio, come ti è venuta questa idea?
Io sono un grande appassionato di calcio, e un giorno mi sono reso conto di aver visto e di ricordare tutte le finali dei mondiali di calcio da Mexico 1970 (avevo otto anni) fino a Russia 2018. Non solo: ricordavo anche con chi le avevo viste e dove, insomma la partita funzionava come un potente stimolatore cerebrale di ricordi. Così è nata l’idea di un romanzo che raccontasse una storia – quella di Pietro, del fratello Giacomo e di Fabiola – che si dipana in mezzo secolo di storia italiana ed è scandita, appunto, dalle finali dei mondiali.
La struttura temporale di Finali, scandita così, di quattro anni in quattro anni, ti è stata d’aiuto nella stesura del romanzo o ti ha complicato la vita?
All’inizio mi ha aiutato: i primi due capitoli sono autobiografici, poi inizia il romanzo vero e proprio: l’adolescenza di Pietro, l’amicizia esclusiva con Lamia, l’esotismo di Buenos Aires. Sono state pagine facili, che ho scritto di getto.
Arrivato ai trent’anni di Pietro – diciamo dal capitolo USA 1994 – tutto è diventato più complicato: Finali non è un giallo (come per certi aspetti è invece Cosa ci rende umani), è la vita di una persona normale, che inevitabilmente tende a diventare meno interessante dopo i quarant’anni, quando le possibilità diminuiscono e gli anni volano. Ma la noia può (anche se non dovrebbe) avere spazio nella vita, non in un romanzo: da qui la necessità di dover sempre inventare qualcosa da far “succedere” ai protagonisti nei quattro anni precedenti alla finale, per convincere il lettore ad andare avanti. Ecco, da questo punto di vista la struttura temporale mi ha complicato la vita, sarebbe stato più semplice saltare o accorpare qualche finale.
In entrambi i tuoi romanzi la sensualità è molto importante, credi che sia uno dei tiranti delle tue narrazioni e che sia in qualche modo collegato alla narrazione di questi uomini sempre alla ricerca di qualcosa?
Certo, la sensualità è importante, non ho mai creduto all’amore platonico e neanche che non possa esistere sesso senza amore (Venditti non sarebbe d’accordo, ma tant’è…).
Ciò premesso, Tommaso e Pietro sono mossi nelle loro scelte, più che dalla sensualità, dalla voglia di trovare un finale diverso per le loro vite. La sensualità irrompe nelle loro vite sotto forma di una donna – Sabine, Fabiola – che certamente li aiuta nel percorso di ricerca ma non è il punto di arrivo della ricerca stessa. Agisce come fattore di cambiamento, ma non più di altre pulsioni che pure li animano: la fuga dalle responsabilità, il desiderio di vivere una vita più semplice, la passione per il calcio, il desiderio di rivalsa, l’amicizia…
I tuoi personaggi sono in cerca di redenzione? Penso a Tommaso, il protagonista di Cosa ci rende umani, che ha un vero e proprio burnout che gli fa perdere la memoria portandolo ad abbandonare il lavoro e la famiglia per trasferirsi a Lisbona e a ricominciare una vita, oppure a Pietro che finisce a Buenos Aires dopo una bravata giovanile finita molto male.
Non parlerei di redenzione, perché Tommaso e Pietro non hanno qualcosa da farsi perdonare, o sono comunque troppo egoisti nella loro ricerca della felicità da avvertirla come tale. Quello che muove entrambi non è il desiderio di redenzione, ma la consapevolezza che abbiamo una sola vita da vivere, che non possiamo sprecarla stando fermi, e per questo sono sempre alla ricerca di nuovi finali per le loro vite (tra l’altro, il titolo Finali vuole rimandare proprio a questo, oltre che alle partite dei mondiali).
Quanto c’è di autobiografico nei tuoi romanzi?
In entrambi i romanzi è autobiografico il punto di partenza: l’esperienza professionale di Tommaso in una banca d’affari che si occupa di acquisizioni è stata per anni il mio lavoro; anche la mia vita, come quella di Pietro, è stata scandita dalle finali dei mondiali, e i primi capitoli di Finali ripercorrono le mie esperienze da bambino a Milano, dove sono nato.
Poi, i protagonisti seguono la loro strada e vivono la loro vita, che si allontana abbastanza dalla mia. Certo, ci sono dei punti di contatto: ambientazioni, vicende personali che si assomigliano, ma Tommaso e Pietro vivono di vita propria.
Ah, ho lo stesso tatuaggio Tommaso…
Ci sono stati momenti difficili, durante la stesura dei tuoi romanzi, che la Scuola Genius ti ha aiutato a risolvere?
Innanzitutto, Genius – con i suoi appuntamenti mensili in cui bisognava presentare una trentina di pagine – è stata fondamentale nel darmi una disciplina nello scrivere. Poi, nel corso degli incontri, mi ha consentito di correggere alcuni errori in corso d’opera, eliminando pagine francamente mal riuscite (si sa quant’è difficile per uno scrittore esordiente rinunciare a qualche pagina che magari è costata tanta fatica…) e privilegiando alcuni personaggi rispetto ad altri.
Ma, soprattutto, mi ha aiutato nella scelta dei finali, che è sempre un momento difficile.
In entrambi i casi, i romanzi avevano finali molto diversi: Cosa ci rende umani aveva un finale “aperto” (anche il titolo l’ho cambiato durante i nostri appuntamenti, inizialmente era “Venticinque chiamate perse”); Finali ne aveva uno troppo simile a quello del Colibrì di Veronesi. Li ho cambiati seguendo i suggerimenti “geniali”; qualche tempo fa mi sono capitate tra le mani le bozze con il primo finale, e devo dire che rileggendole ho pensato: “Beh, davvero non funzionavano!”
C’è un’ora della giornata e un luogo dove ti piace scrivere o ragionare sulle tue storie?
Spesso ragiono sui caratteri dei personaggi o sulle evoluzioni della trama mentre sono in macchina o nelle ore in bicicletta. Soprattutto in macchina, intrappolato nel traffico, detto al telefono impressioni, idee, dialoghi, qualche volta interi paragrafi!
Per entrambi i romanzi avevo un taccuino Moleskine, sul quale – magari mentre ero seduto in un bar – buttavo giù brevi appunti delle scene che avevo immaginato, come se fossero le sequenze di uno storyboard.
Poi la sera, oppure nei fine settimana, nella tranquillità di casa, avvio una delle playlist di Spotify “Musica per scrivere” e mi dedico a scrivere, rileggere, limare.
Per Finali, un romanzo che copre un periodo di cinquant’anni, ho anche dedicato molto tempo alle ricerche: a che ora si giocava la partita, com’era lo stadio, cosa era successo nell’attualità di quegli anni. Con l’”omino” di Google Maps ho percorso avanti e indietro le strade di Buenos Aires, e quando la scorsa estate ho avuto l’occasione di andarci di persona mi ha colpito quanto fossero accurate le descrizioni che avevo fatto!
Quali sono le letture che ti hanno influenzato?
Sono un lettore onnivoro, Goodreads (social nerwork dedicato ai libri – ndr) mi accredita circa 15.000 pagine all’anno.
Credo che tutto mi influenzi, a volte leggo un romanzo e penso: “Vorrei proprio scrivere come lui!”, così può essere capitato che in qualche capitolo mi sia ispirato allo stile dell’autore che stavo leggendo in quel periodo, se mi piaceva particolarmente.
Meno occasionalmente, credo di essere stato influenzato dalle pagine di Javier Marìas sui segreti che ci portiamo dentro e come influiscano sulle nostre vite; e di Andrea De Carlo per la maniera di raccontare i sentimenti e le relazioni di coppia.
E infine, come dimenticare Pessoa e Borges – sono loro le citazioni che aprono i due romanzi – per la malinconia e per la tensione a vivere più vite che esprimono nelle loro opere?
Stai lavorando a un nuovo romanzo?
No, al momento no. Mi sono iscritto all’Università di Roma 3, facoltà di Storia, un desiderio che avevo da ragazzo (poi mi sono laureato in Giurisprudenza). Chissà, magari fra qualche anno scriverò un romanzo “cappa e spada”…