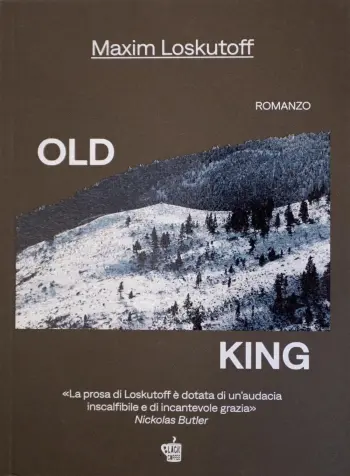È impossibile resistere al fascino discreto di Carlo D’Amicis, scrittore ironico e sorprendente. Quest’anno è entrato a far parte della squadra dei docenti della Scuola di scrittura Genius e se fossimo pescatori diremmo di averne acchiappato uno di quelli gagliardi e giganteschi. Non è di pesca che parliamo oggi, parliamo di caccia. O forse non solo. Più precisamente della riedizione aggiornata del suo romanzo Il grande cacciatore (e altre violenze),Terra Rossa Edizioni. Carlo D’Amicis vive immerso nel mondo dei libri, su Rai3 è autore di Quante Storie e su Rai Radio3 di Fahrenheit. Piccole perle di cultura in un universo di comunicazione generalista. Tra i romanzi precedenti di Carlo ricordiamo Il Gioco, pubblicato da Mondadori e finalista nella cinquina del Premio Strega nel 2018. Nel Grande cacciatore ci racconta la vita intrecciata di due donne, che sembrano instaurare un legame di dipendenza l’una dall’altra. In mezzo a loro ci sono un uomo abbastanza inutile, degli improbabili alieni e un cane meraviglioso. D’Amicis è uno scrittore che ti incanta e ti tortura con dolcezza. Gli abbiamo fatto dieci domande per riflettere insieme a lui sul senso di alcune sue scelte narrative e per carpire almeno uno dei suoi segreti.
Il grande cacciatore (e altre violenze) è un tuo romanzo uscito per la prima volta nel 2011 (Duepunti edizioni) e, adesso che lo hai ripubblicato per un nuovo editore, per tua stessa ammissione ci hai rimesso mano: quali sono i cambiamenti più significativi?
Penso che ogni scrittore debba essere il primo editor di se stesso e cercare di mantenere sempre un atteggiamento vigile, se non critico, nei confronti della propria scrittura. Si può sempre migliorare le potenzialità di un testo e farlo aderire il più possibile a ciò che vogliamo veramente dire. Quindi per me è stato naturale, a distanza di dodici anni dalla prima versione, rimettere mano al Il Grande Cacciatore e cercare una maggiore coincidenza con me stesso, con i miei gusti di oggi e con la mia attuale visione dei rapporti tra le persone (sempre più improntati all’uso dell’altro pur di affermare se stessi). La scrittura, per rispondere meglio alla tua domanda, in questa nuova versione è diventata più fluida, meno frammentata, in un certo senso più amica delle due protagoniste, come se sentissi il bisogno di essere meno severo verso le loro contraddizioni.
È la prima volta che ti capita di rimaneggiare un tuo libro che è stato già pubblicato?
No, mi è già successo quattro anni fa, quando la casa editrice 66thand2nd mi ha proposto di ripubblicare Il ferroviere e il golden gol, un mio romanzo del 1998. Anche in quel caso è scattato il bisogno di far dialogare di nuovo il testo e l’autore, di metterli a confronto in quella che – ci tengo a dirlo – non è un’ammissione di debolezza, né tantomeno un disconoscimento dei libri che ho scritto, ma al contrario la riprova che i romanzi che scrivo non sono degli oggetti, più o meno belli, ma dei veri e propri soggetti che ambiscono a mettere in moto una relazione con il lettore e con lo stesso autore, quando li scrive o quando a distanza di tempo li rilegge.
Come nasce l’idea de Il grande cacciatore?
Lo spunto iniziale era legato al rapporto tra uomo e animale, tema di fondo della collana Zoo, della casa editrice Due Punti, che tra il 2010 e il 2012 ospitò, oltre al mio, testi analoghi di Nicola Lagioia, Giorgio Falco, Giuseppe Genna e altri scrittori. In realtà questo spunto (sul quale, in quel periodo, ho lavorato anche per un romanzo dal titolo Quando eravamo prede, pubblicato nel 2014 da Minimum Fax) mi ha portato a esplorare una relazione ancora più vasta e imperscrutabile, cioè quella tra l’umano e il disumano, intendendo per disumano tutto ciò che ci parla da un certo grado di parentela, e quindi da una distanza ravvicinata, rispetto alla comfort zone del nostro essere persone civili, razionali, padrone di noi stesse. Su questa comfort zone si affaccia l’animale, l’extraterrestre, ma anche e soprattutto lo sporco che ciascuno di noi cerca di nascondere costantemente sotto i tappeti: il rimosso, le nevrosi, le bassezze. L’infermiera e l’ex modella Marilyn, ovvero le due vicine di casa protagoniste di questo racconto, si spingono reciprocamente verso il bordo delle proprie illusorie certezze, vittime di una competizione che ci spinge a sopraffare l’altro pur di impedire alle nostre fragilità di venire a galla.
Leggevo, leggevo… e non riuscivo a capire quali fossero queste “altre violenze” a cui allude la parentesi presente nel titolo, non voglio fare spoiler, ma alla fine ho capito. Sei uno scrittore davvero cattivo, ne sei consapevole?
Penso che le storie debbano essere sempre un po’ cattive. Non nel senso che il male debba prevalere sul bene (questo sarebbe solo il rovesciamento di un luogo comune), ma nel senso di mescolarli, esattamente come sono mescolati dentro di noi. Questa mescolanza di bene e male è in effetti la cattiveria più grande che uno scrittore può fare a un lettore, perché lo destabilizza, lo sottrae alla comodità di pensare alla vita, e all’animo umano, come a un luogo ordinato, caratterizzato da una netta divisione tra i buoni e i cattivi, i torti e le ragioni. Oltretutto, una concezione così falsa, manichea e consolatoria è il presupposto ideale, secondo me, per legittimare un mondo basato sui rapporti di forza e di potere – esattamente quello che la letteratura, intesa come impegno, dovrebbe cercare di non fare.
La tua scrittura è molto veloce, tanto da dare un sapore un po’ surreale alle dinamiche e alla storia, come ci sei arrivato?
Le caratteristiche di una scrittura (quello che spesso si chiama stile) sono anche l’espressione del modo di essere dei personaggi, soprattutto se, come in questo caso, uno di loro, l’infermiera, parla in prima persona. L’infermiera (così come la sua vicina Marilyn) è impegnata in una continua opera di rimozione delle proprie debolezze, delle proprie angosce, delle proprie miserie. Non può quindi permettersi più di tanto di soffermarsi su ciò che veramente prova, le sue reazioni devono essere rapide, sfuggenti anche a se stessa (almeno fino al momento in cui l’incontro con il cane non la costringerà a un passo un po’ diverso). Più in generale posso dirti che tutti gli sforzi che faccio sulla mia scrittura sono riconducibili a un tentativo di riconciliazione degli opposti: essere semplice e complesso, essere chiaro ed enigmatico, essere veloce e profondo, essere ironico e tragico… la scrittura letteraria richiede dei requisiti spesso in apparente contraddizione tra di loro, venire a capo di queste contraddizioni è una sfida difficile ma è anche ciò che distingue la letteratura da qualunque altra forma di comunicazione.
In questa storia mi sembra ci sia anche molto cinema, le immagini che rappresenti sono sempre molto forti, la prima tra tutte mi è piaciuta tantissimo, all’inizio del romanzo: la protagonista che vede il suo fidanzato, Adelmo, fare sesso con la vicina, Marilyn… Ci sono film o registi a cui hai pensato mentre scrivevi?
Non direttamente, ma ho sempre guardato film non meno di quanto abbia letto libri, quindi l’immaginario cinematografico è sempre piuttosto attivo nella mia mente. Come per gli scrittori, cerco di conoscere e di farmi affascinare da registi molto diversi, per cui è difficile dire che uno mi ispiri in modo particolare. Amo il noir francese e le commedie di Billy Wilder, i fratelli Cohen e il cinema pittorico di Pasolini, ma arrivo volentieri ai poliziotteschi e perfino ai cinepanettoni – insomma, una babele nella quale ormai domina l’inconscio più che la citazione consapevole.
Le due donne, le due vicine di casa, si amano o si odiano?
Sarebbe fin troppo facile dire che fanno l’uno e l’altro. In realtà, a pensarci meglio, l’infermiera e Marilyn sono due donne che non sanno né cosa sia l’amore né cosa sia l’odio, galleggiano come tanti di noi in una zona grigia dominata da false convinzioni, illusorie consapevolezze, e soprattutto dalla paura di conoscersi davvero. Questa paura rende l’amore niente più che una suggestione e l’odio niente più che un risentimento: forme lievi, equivoche, di sentimenti ben più profondi, ma non per questo meno pericolose delle reali passioni – anzi, sono proprio questi surrogati sentimentali, oggi più che mai, a generare violenza e sopraffazione.
Perché un lettore dovrebbe leggere Il grande cacciatore (e altre violenze)?
È una domanda che mi procura un certo imbarazzo. Con quale faccia tosta uno scrittore può dire leggete il mio libro, quando sa che autori come Dostoevskij, Bernhard o Nabokov prendono polvere sugli scaffali di tante librerie? Questo forse ti dice qualcosa sulla mia posizione rispetto alla deriva social che ha preso (anche) il mondo editoriale, dove predomina il libro come prodotto, dove si esalta la novità, dove gli autori sono chiamati a vendere (o a vendersi) come dei piazzisti. Ecco, forse è proprio questa una delle possibili ragioni per avvicinarsi a Il grande cacciatore (e altre violenze): il fatto che questo piccolo libro non ammicchi alla dilagante modalità consumistica, ma tenti di mettersi in comunicazione con un’idea di letteratura più appartata e, spero, più resistente.
Quali sono gli autori che sono per te fonte di ispirazione?
Anche per i libri vale il ragionamento fatto con i film: l’immaginario letterario è molto stratificato e sedimentato nel tempo. I tre scrittori nominati poco fa, però (Dostoevskij, Bernhard, Nabokov) rappresentano bene lo spirito che mi ispira quando scrivo: provare cioè ad affrontare la complessità dell’animo umano senza pregiudizi, con compassione e rispetto, provando a trovare la bellezza nel nostro disordine.
Tu credi nella fratellanza cosmica?
Ah, ah, ah, per rispondere a questa domanda devo prima farmi autorizzare da Marilyn e da Adelmo, non vorrei che poi mi sparassero al gatto!