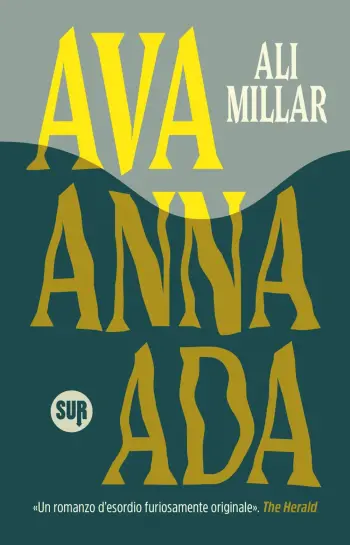Ogni volta che viene a Roma mi vuole perlomeno seduto in mezzo ai suoi. Ancora adesso i miei si stupiscono che sia lui perlopiù a tenersi in contatto con me. Fin dal ’76, quando ci capitò di conoscerci d’estate, a casa sua. Io ci stavo per un corso, il primo finanziato da mio padre, tipo full immersion. E lui si stava già fissando col reggae perché, pochi lo sanno, anzi quasi nessuno lo ha davvero capito, della musica a lui interessano le implicazioni umane, l’espressione di ciò che è radicato nelle comunità, e per la stessa ragione gli è sempre piaciuto fare teatro in musica, i musical, storie piene di canto e racconto. Fin da che era ragazzo, ancora prima di incrociarci. Nel ’76 era ancora in trio e doveva aver già capito che gli sarebbe toccata a breve una lunga strada da solista.
Chi s’impegna a denigrarlo fa notare che possiede una nave in cui all’alba costringe il personale di bordo a lustrare la chiglia e il castello di cabine a vetri in modo che poi sotto il severo sole estivo tutto luccichi e brilli, e anche i piccoli cabotaggi risultino scintillanti, e, sebbene con signorile discrezione, il panfilo coi suoi occupanti non passi inosservato tra la gente di mare – che è sempre stata sprucida, anche se oramai tutto si è guastato. Però pochi sanno, e nessuno o quasi calcola, che il suo rapporto col mare è genuino. E atavico. Legato ai vecchi cantieri della sua città, ora definitivamente dismessi: la vera anima di quel magnifico posto.
Quando siamo diventati amici mi ha portato a vederli: funzionavano ancora a tutto vapore. Il varo di ogni nuovo scafo era un avvenimento. Carrelli catene e cordame che permettevano accadesse erano una macchina sferragliante. Una tale macina di clangori e muri d’acqua che lo stupore e lo spavento furono la mia ingenua reazione. Figuriamoci, io ho pensato subito alla Pequod, al capodoglio inabissato tra gli spruzzi col suo bagaglio di cime arpioni e uomini intrappolati sui fianchi, al capitano Achab con addosso in scala le stesse scalfitture incise nel corpaccione indomito di Moby Dick. I cantieri erano una fabbrica, per me furono un mostro.
Quando siamo diventati amici mi ha portato subito a vedere un altro posto.
Come un fratello maggiore, per svezzarmi: insegnarmi come sbrigarmela con le ragazze.
Il termine del muro è un sito archeologico, dopotutto. Chissà quante volte aveva provato a raccontarlo alle allieve della scuola di suore dove è stato per poco un professorino di lettere: ragazzine infernali in trepidante attesa di saltargli addosso senza reticenze. Dopotutto la sua sola presenza in classe in una scuola che prevedeva il suggerimento contro natura alla castità era una provocazione. Le lolite, mentre se lo mangiavano con gli occhi, lo imploravano mute di non star loro così vicino. Anche lui invocava distanza.
Quando mi ha portato al termine del muro, non mi ha tenuto una lezione sui romani, sui due muri, sulle loro diverse funzioni come confini posticci. E non si è sognato di insultare i combattenti oramai disarmati, pronipoti dei fieri guerrieri dipinti. Con un buon gusto che mi è parso fin dall’inizio il suo tratto più autentico, con una franchezza grandiosamente ruvida, non ha voluto in effetti insegnarmi granché. Senza sapere niente di me, ignorando che io già brigavo con le ragazze senza nessuna intenzione di legarmi, che facevo ginnastica al mare con la mia compagna di doppio e piaceva a tutti e due, cioè né Leonia né io avevamo inibizioni perché ci piaceva giocare in allegria, mi disse solo: Quando voglio fare colpo su qualcuna, la porto qui.
Fare colpo, volendo, può essere un problema. Gli capita di far colpo subito, ma molto se ne preoccupa. Quando si è davvero innamorato, ha passato le pene dell’inferno. Era già sposato, e aveva figli piccoli. Ma vide lei e perse la testa. E cominciò a patire come un cane. Non sapeva come mettersi. Era ancora molto giovane, era bello, il suo successo era appena meno che planetario, ma era l’uomo più distrutto della terra. E poi soffriva per i suoi. Per suo padre che gli sembrava un uomo disperato, prigioniero di una tristezza congenita: era la dignità del lavoratore serio, incapace di animarsi per tutto ciò che piaceva a sua moglie – l’opposto esatto della ricerca della felicità. Loro due lo facevano piangere, e si chiedeva se fosse giusto: suo padre era il suo tarlo. Pensare a lui gli toglieva coraggio. Gli faceva pena e tenerezza insieme, una fregatura.
Per un periodo, si trovò in una specie di terra di nessuno. Si era innamorato senza dubbio e come un pischello dubitava che lei lo ricambiasse, e intanto era marito e padre. Un guaio. Non si direbbe che uno come lui possa aver attraversato un’incertezza così umana, lui che ha l’aspetto e la sorte di un dio. Quando ci è capitato di conoscerci, io ero coetaneo di un suo fratello nato come me nel 1960, e lui era già un uomo. Una sera tornò a casa da un giro di concerti. Piombò coi due compari. L’americano con la scucchia era un tipo allegrissimo, anche troppo, un po’ sparone. L’altro mi parve subito non c’entrasse niente con loro due: media statura, mediterraneo, scuro, si faceva chiamare Henry ma il suo nome era Henri seguito da un cognome italiano detto alla francese – sorrideva, rideva. Un buon chitarrista còrso.
Arrivarono sul finire della cena, nel momento in cui stava per aprirsi quel fertile scorcio serale in cui si va al pub, e a fare musica in qualche locale.
Mi fece: Italiano, cosa suoni? Chitarra, gli risposi. Lui la scippa al còrso che si fa sotto senza mettere su un’aria davvero offesa, o piantarmi seriamente il muso: Henri non pare affatto geloso del suo strumento né d’essere l’unico chitarrista del gruppo. Quanto a me non ho precisato di aver cominciato dal pianoforte, né ho rivelato che appena ero entrato in possesso della mia prima chitarra (regalo di Gianni mio padre che ha sempre compiuto piccoli attentati alla nostra pace familiare, mi rendo conto), lo studio diligente del piano mi era parso farisaico: subito avevo ceduto alle tentazioni irriverenti e al facile miraggio dell’insubordinazione promessi dalla chitarra.
Il mio amico, con gesto rapinoso e smorfia malandrina, soprattutto con un lampo luciferino negli occhi, mi butta addosso la chitarra di Henri il còrso, Suona!
Erano appena dieci minuti che ci conoscevamo: anzi non ci conoscevamo, eravamo solo nella stessa stanza. Chitarra acustica con amplificazione. Non la elettrificai. La imbracciai con la sensazione di stare a un provino per un posto di maestro in un’orchestra sinfonica (allora non sapevo che lui aveva già il pallino della sinfonizzazione del pop, sempre per via dei musical a teatro). Attaccai il giro di do che apre Smoke On The Water dei Deep Purple, un riff facile, suggestivo, avvolgente. Chi suona, parte da lì.
Entrai in una specie di loop, e loro mi vennero dietro, improvvisando una sessione ritmica con posate e bicchieri, tutti e tre. Eravamo in un tinello in una casa di gente normale, zeppa di figli, ma in quel momento sembrava di stare in un locale della magnifica scena musicale inglese che in quegli anni era in sobria ebollizione. La sobrietà, che lui poi ha anche cantato, la Brit sobriety, consiste in una compostezza che non offusca lo smalto del successo: semmai lo ridimensiona, evita che il divismo s’ingoi tutto. A un certo punto, sempre avviluppato nel riff dei Deep Purple, sostenuto dalla persistenza del ritmo e del battito forniti dal trio di musicisti veri, mi sono alzato in piedi e ho cominciato a inarcarmi e agitarmi manco fossi Jimi Hendricks.
Lui è partito con applausi e yahoo! di entusiasmo. Mi ha abbracciato di slancio senza nemmeno aspettare che togliessi di mezzo la chitarra, ripresa delicatamente per evitare cocci del compassato Henri. L’altro, l’americano, ha provato a colpirmi con la scucchia sbottando in una risata, mobilissimi gli occhi. Bè, il mio amico ha occhi penetranti, chiari e fondi. Il suo sguardo è una lama. Ci ho fatto caso subito, già quella prima volta. Però allora aveva un viso troppo mobile. Col tempo si è calato addosso una impassibilità che fa di lui un’icona, e rende la sua espressione esemplare, dimostrativa, e poi autorevole: non da uomo comune, quasi da guru.
Lo ha imparato dallo yoga e dall’esplorazione delle culture sciamaniche di cui è curioso e rispettoso. Eppure lui sostiene di averlo imparato da me. Ti ho osservato, mi ha detto un giorno: eravamo da lui in campagna davanti al camino acceso, con le chitarre, stavamo improvvisando quel suo pezzo in cui dice di non essere un simulatore, di non barare mai nemmeno al gioco, di avere una sua lealtà inflessibile. Il tuo punto forte sono gli occhi, diceva, lui a me, puntandomi addosso lo sguardo magnetico: colore e taglio. La tua faccia proviene tutta ed è calamitata dal grigio ghiaccio e dalle mandorle a feritoia: uno sguardo indagatore, segno di un lavorio mentale ed emotivo fitto. Ha una certa vena poetica, il mio amico.
Lui sostiene di aver imparato dalla mia compassatezza, dall’attenzione che dice io metta nella valutazione dei segni inconsapevoli che chiunque mi offre, da cui io metto insieme le mie diagnosi a piede libero senza muovere un solo muscolo, solo puntando lo sguardo come un faro. Come un cone beam, ci ho scherzato su io. Ha capito, sostiene, osservando me, che non bisogna scomporsi: ci si deve contenere in un aplomb che in verità io ho sempre visto in lui – del resto è o non è lui il gentiluomo britannico? E poi è un pennellone. Io lo raggiungo appena. Sarà questa la vera differenza tra chi è uomo del nord e chi no.
Sulla carta io sarei bruno: si vede bene dalla pelle che al sole scurisce di botto, in mezza giornata quando sono in barca divento nero. Ma il bello è che, specie da ragazzino, i miei capelli tiravano fuori la loro anima bionda, diventavano gialli. Sarà per questo che la gente mi guardava con gli occhi da fuori e io maturai l’idea d’essere un mostro: avevo in testa un manto da tigre. Fino a poco fa schiarivano con venature rame, ora sono solo grigi.
Le amiche di Ilaria mia madre, ricordo, già mi sparavano i fari addosso da bambino. Poi al mare da un’estate all’altra sono cambiato: al posto del bimbo da cullare c’era un ragazzetto lungo e sinuoso da inseguire.
Le madri cominciarono a gettarmisi addosso con la scusa che ero sempre io, il ragazzino che avevano visto crescere insieme ai propri figli. Proprio come il Don Juan di Byron, mi ha spiegato il mio amico, un adolescente sensuale inconsapevole di destare le voglie delle donne sposate, seppur giovani ancora, però già stufe dei loro gelosissimi mariti, che daranno anche loro la caccia, a scopo di vendetta, al giovanissimo amante suo malgrado. Mi davano la caccia, le giovani signore che avevo sempre considerato delle zie, ma io, a differenza del personaggio byroniano, non ci stavo. È così, gli ho spiegato, che sono diventato forastico.
Avere addosso gli occhi degli altri, essere mangiati con gli occhi: ci capita, sia quando siamo separati che, soprattutto, quando siamo insieme. Per dire, al ristorante. Una sera mi ha invitato in un posto di lusso: io ero a Milano per un convegno sui dosaggi scalari degli oppiacei e l’uso dell’elastomero nel dolore severo, traumatico cronico o terminale. Non ero affatto libero: lui credeva fossi solo e abbandonato al mio solitario destino, ma ho dovuto lottare per sganciarmi da una truppetta di colleghe che mi hanno voluto fino all’ultimo.
Con noi a tavola, l’irlandese con moglie, e poi lei, la sua struggente compagna. Forse avrei sofferto meno a vociare a vanvera in una trattoria con i miei colleghi: senza Sandra con me, mi pareva di essere un po’ finito alle corde.
Ma solo all’inizio. Poi abbiamo cominciato a ridere e scherzare, e lui ha detto al collega che, quando siamo per strada insieme, prima tutti guardano lui solo, perché è conosciuto, ma subito dopo puntano insistentemente me, e le donne smettono di corteggiare lui per correre dietro a me. Io mi sono subito schermito, ho negato tutto. Allora lui con tono diverso, m’è parso, quasi con una sorda volontà denigratoria o vendicativa, ha incominciato a lodare il mio modo di suonare, come un professionista!, e a rimproverarmi, parlando solo con l’irlandese, come se io non fossi lì con loro, Potrebbe stare nella mia band tranquillamente, sa tutti i pezzi e li canta e li suona a memoria: fa il prezioso, capito? A me invece lui servirebbe come il pane.
Niente da fare, lui vuole fare il medico. Non è che io faccia il medico, io sono medico!
Lo stesso ho fatto col tennis: ho allenato fior di campioni al Foro Italico come sparring partner ma non ho mai tentato di imbarcarmi nel carrozzone del professionismo. Eppure il presidente della federazione a suo tempo ha implorato mio padre di convincermi a fare lo sforzo di passare da classificato a professionista.
Io sogno solo di stare in barca, di esplorare il mondo via mare, invece sono in chirurgia ogni giorno – il mio ospedale è un’isola, ci vado a piedi o in bici, all’alba, sono sempre presente e ho una montagna di ferie non godute.
Il direttore sanitario ogni anno mi convoca per convincermi a farmelo, una buona volta, questo benedetto giro del mondo in solitaria.
L’idea mi è venuta proprio il giorno in cui il mio amico mi portò ai cantieri.
Veder costruire e poi varare le navi non è lo stesso che vedere nascere barche motoscafi gommoni. Una questione, di nuovo, scalare. Una faccenda di dimensioni, di magnificenza e terrore, e di immaginazione del bacino d’acqua che dovrà ospitarli. Mari alti e oceani. Maestosità del mezzo e del luogo, e ridimensionamento del navigante. Solo nel mare. Imparerei meglio che siamo poca cosa rispetto all’immenso mondo che ci contiene.
Il mio amico lo sa quanto me. Al fondo mi pare questa la sua poetica. Siamo fragili e sguarniti, tutti noi esseri della terra. Voler bene attenua lo smarrimento, lui ne è convinto.
Come il cigno spesso saccheggiato per i testi, coltiva la generazione come antidoto, più che all’estinzione della specie, alla sparizione di ciascuno di noi. E dire che io sono stato a lungo avverso a generare. Credevo di salvare i figli dal dolore della vita non facendoli nascere. Ed ero inflessibile su questo punto. La mia presuntuosa filosofia preservativa. Ma la mia roccaforte è stata insidiata fin dalle basi: il patto di non gestazione l’avevamo stipulato in due, Sandra e io, e lei è sempre stata più vitalista di me – più generativa, ecco.
Così lui ha dedicato a noi due una canzone. Quando la suona, pensa a me, a quei giorni d’estate del mio primo (inconsapevole) concepimento, a lunghi capelli misti al grano, al vento d’estate. Un’immagine di fertilità, più naturale della mia ostinazione a negar nascite.
Il vero paradosso, più dei tre figli che sono seguiti, è che io sono un mago dell’epidurale. Aiuto a farne nascere. Da perderci la testa. Quando mi capita di sentirla alla radio o la suoniamo o lui la canta in concerto, mi sento chiamato in causa: le parole, le frasi melodiche mi investono. Lui dice che quella canzone sono io. Io non riesco a cantarla: perché dovrei? Descrive me, o meglio descrive noi, Sandra me e i figli, nell’oro dei campi come loro due, lui e la sua struggente compagna, e la numerosa prole.
Le distese d’oro erano campi d’orzo, di fronte alla casa sul lago. In seguito Gianni mio padre gli ha trovato una diversa soluzione che prevede filari e giardini di ulivi, e l’umile opera di raccolta. Che ha qualcosa di biblico. Come certi re sulla scena, umani e ignudati.
Come David che perde la testa per Bathsheba, regina ittita: Ammattisco per te. Lui ironizza sempre: God is not pleased! E nel grido d’amore di David echeggia la rabbia di Dio: Ce l’ho a morte con te! Una rivista ganza che si occupa solo di rock e divi pop ha stabilito, con un finto sondaggio, che lui non sa scrivere canzoni: da perderci la testa.
Se c’è uno che sa scrivere canzoni, questo è lui. E se gli chiedi come fa ti dice che non lo sa.
L’unica certezza è che deve conquistarsela ogni volta, la felicità: Parto dalla musica, dice, è la musica a suggerirmi la storia, poi aspetto che le sensazioni e le persone vengano a visitarmi, che si presentino da sole, ogni volta è diverso. Hanno pure insinuato a un certo punto che stonava perché stava diventando sordo. Da perderci la testa. Io so solo che con le sue mani da lavoratore tocca con grazia il suo basso Fender o una chitarra o un banjo oppure schiaffeggia i sonagli del cembalo agganciato all’asta del microfono o al leggio, e ciò che ne esce quasi non è di questo mondo.
Il rendering pubblico dei concerti è sporadico rispetto all’immanenza della musica nelle nostre vite. Nelle nostre menti, e nelle nostre mani. In questi giorni ho un periodo di prestazione d’opera all’oncologia pediatrica del Mount Sinai. Lui mi ha subito offerto ospitalità a casa sua nel west side: attraversando a piedi o in bici ogni mattina il parco centrale, esattamente come a Roma sarei in ospedale con una bella passeggiata. Ma mi hanno dato una casa, a Willy, 10 minuti di metropolitana e un breve tratto a piedi: come se arrivassi dalla sponda di fronte. Un’offerta che tecnicamente non ho potuto rifiutare.
Stasera sono con gli altri alle prove in teatro. I musicisti, a parte la band di base, sembrano tutti capitani di lungo corso: barbuti con camicie a quadri jeans e stivali, compreso il mio fraterno amico. La vocalist, unica donna tra tanti omaccioni, non ha resistito: adesso è un maschiaccio. Nick e io canticchiamo e scaldiamo le chitarre. Il batterista se la ride in anglo–napoletano, e il percussionista si sistema le chiome inanellate da kouros greco, benché venga dai deserti del Nord Africa. Stare tra questi giganti ed essere stimato e amato, essere incluso come un fratello ritornato, è pazzesco: un privilegio sul quale non ho mai perso la testa.
Sono solo felice.
Sono dentro la musica con loro.
Siamo dentro la musica, senza distanze, tutti insieme:
Tranquillo, mi sussurra il mio amico,
intanto mi sta massacrando una spalla con le sue mani da lavoratore piene di grazia,
siamo tutti niente.
Sapevo che me l’avrebbe detto.